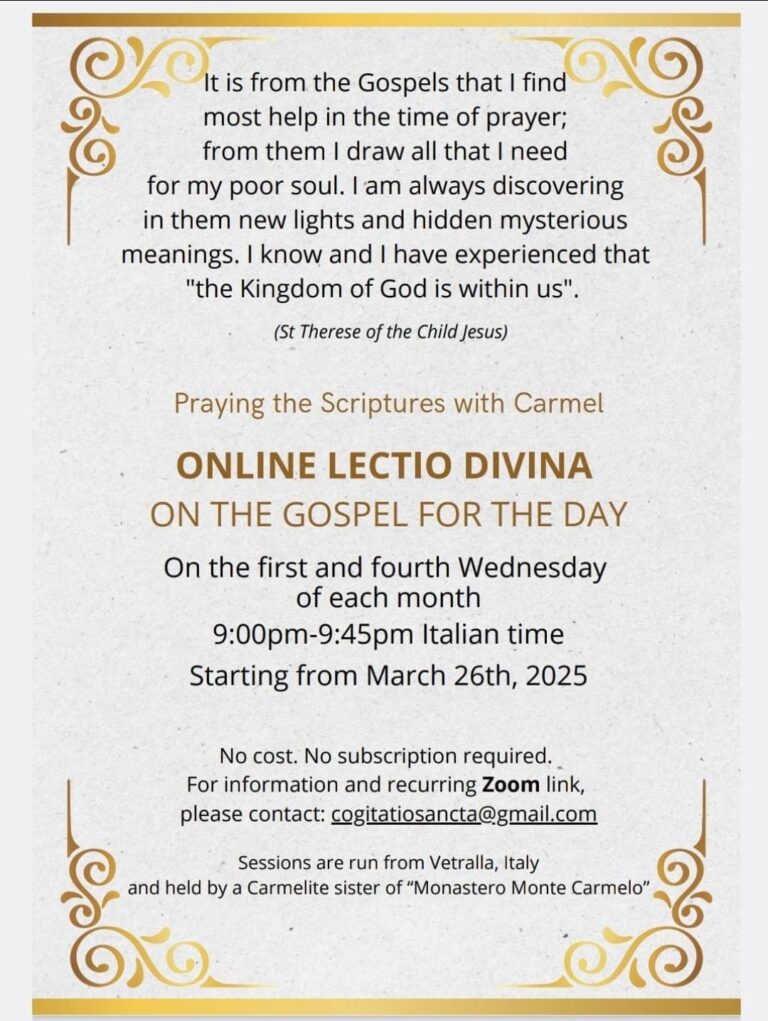IV DOMENICA DI QUARESIMA Lc 15,1-3.11-32
La bella (anche letterariamente: è riportata pure in antologie di testi greci) parabola del padre che si commuove e accoglie con gioia autentica il figlio, detto comunemente “figlio prodigo”, quando ritorna dopo uno sbandamento viene raccontata per rispondere a “farisei” e “scribi” che mormoravano contro Gesù: “Costui accoglie i peccatori e mangia con loro”. Si tratta fondamentalmente della visione che si ha di Dio: come uno lontano che dà le sue direttive e controlla severamente che siano rispettate, oppure un Dio che, pur trascendente, si lascia guidare dalla “condiscendenza” verso l’uomo, si prende cura di lui con tenerezza. Gesù, manifestazione umana di Dio, certo è del tutto intransigente verso il male, ma in modo assoluto accogliente verso chi lo commette, intransigente verso il peccato, ma misericordioso verso il peccatore in vista della sua conversione (cf. Gv 8,11). Anche il Corano, il libro sacro dei Musulmani, pur con le molte divergenze rispetto al cristianesimo, ha il ritornello: “Nel nome di Dio clemente e misericordioso”. Non è che si possa intendere Dio come un bonaccione che alla fine chiude un occhio su tutto e accetta tutti indistintamente; rimane sempre vera l’affermazione pregnante di S. Agostino: “la prima verità dell’amore è l’amore della verità”; il male rimane sempre male, non puoi dire al tuo amico che una cosa va bene per fargli un piacere, se non è così; se gli vuoi bene davvero, devi dirgli la verità, certo mai mancando al rispetto.
La parabola evangelica è ben segnalata al suo inizio “Disse poi” (“Eípen dé”) (cf. v.11), mentre alla fine risulta più sfumata (sotto se ne darà una spiegazione plausibile), delimitata solo dal fatto che dopo comincia una nuova unità letteraria (cf. 16,1). Nel racconto stesso vi sono molte cose inverosimili: es. la macellazione e la preparazione del vitello grasso sono assolutamente incompatibili col “presto” (“taḳý”), è difficilmente pensare che che si faccia una festa senza coinvolgere l’altro fratello, ma non si deve dimenticare che si tratta di un racconto congegnato per trasmettere insegnamenti, né la differnza fra “tempo della narrazione” e “tempo narrato”. Si prendono in considerazione i tre protagonisti: i due figli, le cui unità letterarie sono introdotte rispettivamente dalla semplice congiunzione “e/kaí” e dalla particella “dé”, e il padre che appare sulla scena accompagnato dal genitivo assoluto riferito al ritorno del figlio minore.
Quest’ultimo è presentato come un autentico peccatore: il vangelo non gli fa sconti, non lo idealizza. Egli non sa apprezzare il rapporto col padre, l’appartenenza alla famiglia; vuole avere una vita indipendente, da condurre a proprio piacimento: pretende l’eredità prima del tempo (anche questo è un caso non contemplato dalla storia reale), va via dalla casa paterna, “per un paese lontano”; il termine si può ritenere evocativo dell’idea della lontananza da Dio, del desiderio di sottrarsi a lui (cf. Sl 139[138],7-12; Gio 1,10;…). Là sciupa tutto “vivendo in modo dissoluto”, così si trova “nel bisogno” e, sommo degrado per un ebreo, viene mandato a “pascolare i porci”, animali ritenuti intoccabili perché impuri; allora rientra in se stesso, dal contesto pare non per motivi ideali (comunemente si parla di pentimento, è possibile, ma in dipendenza dal bisogno), bensì per necessità, perché ha fame: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!”; si rende conto che solo nella casa del padre può vedere soddisfatte le proprie esigenze e decide di tornare con la richiesta realistica di essere preso almeno come salariato. Anche se inizialmente spinto dal bisogno, ha il coraggio di riconoscere la sua scelta errata e di ritornare sui suoi passi. In fin dei conti, anche nella formula tradizionale dell’“Atto di dolore” ci si dichiara addolobrati, partendo da un motivo “egoistico”: “perché ho meritato i tuoi castighi”, solo in un secondo tempo, quasi in un sussulto di coscienza, si aggiunge e precisa: “molto più perché ho offeso te…”
Il padre è una figura gigantesca: asseconda il secondogenito, senza alcuna opposizione, esplode di gioia quando egli ritorna: “avendo corso, gli si gettò al collo e lo baciò”. Non bada alle convenzioni sociali, secondo cui un orientale adulto di una certa dignità non può mettersi a correre, deve stare sulle sue, senza abbandonarsi a facili effusioni affettive (è del tutto infantile): si lascia tutto prendere dalla gioia indicibile per il ritorno del figlio ed è interamente dominato dall’attenzione a lui. Dio accoglie il peccatore quando ritorna: vale anche qui quanto è detto esplicitamente per le altre due parabole, che c’è gioia davanti a Dio per “un solo peccatore che si converte” (vv.7.10). Il peccatore non cessa di essere figlio, Dio-Padre continua ad amarlo. Nell’immagine delle tre parabole si esprime la gioia per aver ritrovato ciò che si era perduto; in ognuna c’è praticamente il medesimo ritornello: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta” (v.6); “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto” (v.9); “… facciamo festa, perché questo mio figlio… era perduto ed è stato ritrovato” (v.24). Il padre “lo vide, ebbe compassione…”; il verbo così tradotto indica il tipico amore fisico che ogni mamma prova per il frutto del suo grembo; così è la tenerezza che il padre sente per il figlio che ritorna, che Dio-Padre prova per il peccatore convertito. Si tratta del verbo “σπλαγχνίζομαι”, forma passiva, deponente del greco ellenistico; nel NT è usato sempre al passivo-deponente: 12 volte, e soltanto nei Vangeli sinottici, sempre con soggetto Gesù, tranne qui e nel racconto del buon samaritano (cf. Lc 10,33). Ma il padre della parabola indica Dio-padre che accoglie i peccatori convertiti; similmente il buon samaritano che si prende cura di chi “è caduto nelle mani dei briganti” rappresenta Gesù che si china sull’umanità ferita e malata. Così anche in Lc, dove il verbo ricorre tre volte, esso ha sempre un soggetto divino; la terza volta si riferisce a Gesù nei confronti della vedova di Nain (cf. 7,13).
Il padre si prende cura anche del figlio maggiore: esce fuori pure incontro a lui (ancora non curandosi delle convenzioni sociali, secondo cui il superiore aspetta l’inferiore); mentre aveva impedito la confessione del secondogenito, sta ad ascoltare sino in fondo la lamentela del primogenito. Gli richiama il rapporto di comunione: “… tutto ciò che è mio è tuo…” e lo corregge in modo molto significativo; quegli aveva detto con una punta di distacco e di riprovazione: “… questo tuo figlio…”; lui dice: “… questo tuo fratello…” : il mio figlio è tuo fratello. Il rapporto di fraternità dovrebbe portare a gioire per il bene dell’altro, non a sentirsi in qualche modo menomati (come purtroppo porta a fare l’istinto: se uno ha successo ci si sente in qualche adombrati).
Il figlio maggiore ragiona in pratica, come gli operai della prima ora (cf. Mt 20,12), come il fariseo che va a pregare nel tempio assieme al pubblicano (cf. Lc 18,10-14): parla di se stesso, ha con il padre (Dio) un rapporto di tipo “commerciale”, accampa diritti per quello che fa.
Il racconto in sé rimane come sospeso: non dice se il figlio maggiore si lascia convincere ed entra in casa a far festa per il fratello tornato; la risposta la deve dare ognuno col suo atteggiamento verso gli altri. Ma risulta chiaro che, solo riconoscendo il peccatore come fratello, si può essere veri figli del Padre, si agisce in unità di intenti con lui. La parabola annuncia il grande misericordioso amore del Padre; proprio questo obbliga ad amare i fratelli: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36).